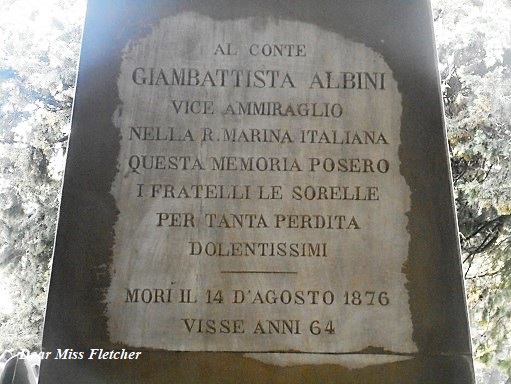Questa è la storia di un eroe del popolo, un fiero patriota al quale dobbiamo la nostra grata riconoscenza.
Uomo di semplice estrazione sociale, Francesco Moro nacque a Genova nel 1821 ed era un fervente seguace degli ideali di Giuseppe Mazzini.
Figura anche il suo nome tra coloro che furono coinvolti nei moti di Genova del 1857, l’insurrezione era stata organizzata in ogni dettaglio, come racconta lo storico Attilio Depoli nel libro L’emigrazione politica in Genova e in Liguria dal 1847 al 1857 volume III pubblicato dalla Società Tipografica Editrice Modenese nel 1957.
Sul finire di giugno doveva attuarsi l’impresa di Carlo Pisacane e da principio, secondo i piani di Mazzini, pare che i moti di Genova e Livorno dovessero verificarsi prima della spedizione di Pisacane alla volta del Sud.
Pisacane era di un’idea diversa, così si stabilì che appena si fosse avuta notizia a mezzo telegramma dell’avvenuto sbarco della Spedizione di Pisacane nelle terre napoletane sarebbero esplose anche le sommosse a Genova e Livorno, questo doveva avvenire nella notte tra il 28 e il 29 Giugno di quel 1857.
A Genova il fervore politico era alimentato e accresciuto nei circoli e nei comitati delle Società operaie, il pensiero mazziniano faceva battere forte i cuori e accendeva gli animi.
Come è noto, l’impresa di Pisacane terminò con l’eccidio di Sanza, con la morte di Pisacane e con l’arresto dei sopravvissuti, il moto di Genova nel frattempo non ebbe successo.
Si narra che, in quella notte prescelta, ci fosse un gran movimento dalle parti di Prè e in Via di Vallechiara, in quella zona e nei vicoli vicini c’erano anche i depositi di armi.
I fili del telegrafo tra Genova e Torino vengono troncati, i rivoltosi puntano ai forti, all’assalto di Forte Diamante risulta che ci siano una cinquantina di persone e tra di essi si dice che ci sia anche lui: Francesco Moro, detto il Baxaicò.

A leggere la sentenza del processo risalente all’autunno di quell’anno ci si accorge di quanto fosse variegata la compagine mazziniana.
La sentenza elenca tutti gli accusati, a quell’epoca 49 di loro sono già detenuti e fra di essi c’è Francesco Bartolomeo Savi giornalista, poeta ed insegnante, c’è il Marchese Ernesto Pareto, noto amico di Mazzini e c’è anche Miss Jessie White, definita sedicente letterata.
E poi c’è un popolo di ardenti patrioti: sono sarti, calzolai, ombrellai, caffettieri, orefici e falegnami.
Sono padri e figli dell’Italia, i loro nomi significano giovinezza e coraggio, alcuni di loro poi hanno dei soprannomi che raccontano il loro furore e così vorrei ricordarne alcuni:
Alessandro Gaggi, sarto di anni 23, detto l’Inferno.
Antonio Valla, facchino di anni 23, detto il Medaglia.
Carlo Banchero, oste di anni 19, detto Moschetta.
Noli Paolo di anni 19, fabbricante d’armoniche, detto Figlio della bella Manena.
Nomi che narrano di gioventù, sfrontatezza, patriottismo e grandezza d’animo.
E tra questi nomi lui: Francesco Moro, di anni 38, facchino, detto Baxaicò, detenuto già dal 2 Luglio.
Baxaicò in genovese vuol dire basilico e non sapete quanto mi piacerebbe conoscere la ragione di questo nome di battaglia!

Ci sono anche 22 latitanti, il primo della lista naturalmente è lui, l’istigatore di tutte le rivolte e delle insurrezioni: Giuseppe Mazzini.

Monumento a Giuseppe Mazzini di Santo Saccomanno – Palazzo Tursi (Genova)
Francesco Moro, facchino da carbone, uomo che conosceva il valore della fatica e del lavoro, fu condannato per quei fatti a 20 anni di lavori forzati e a 10 anni di sorveglianza.
Scontò una breve parte della sua pena e lasciò il carcere a seguito dell’amnistia del 1859.
Da allora fu sempre in prima linea e partecipò a tutte le campagne fino al 1867, era stimatissimo da Garibaldi che lo teneva in grande considerazione.
E tra i volontari giunti a Marsala, al seguito del nizzardo c’era anche lui, Francesco Moro.
Il patriota lasciò le cose del mondo in un giorno d’autunno del 1874.

Egli riposa in un luogo particolare, all’ombra degli alberi nel Boschetto Irregolare del Cimitero Monumentale di Staglieno dove è eretta la stele in sua memoria.

Se salirete fin lassù, percorrendo la scalinata, cercate la tomba del più illustre genovese, quel Giuseppe Mazzini che con il suo pensiero guidò questi valorosi ed eroici patrioti.

La stele in memoria di Francesco Moro è stata collocata proprio qui, davanti al tomba di Giuseppe Mazzini, quel grande italiano del quale l’umile facchino era amico e seguace, i due dormono il loro sonno eterno così vicini.

Sul marmo sono incise molte diverse parole in memoria di Baxaicò.

E alcune di esse che potete leggere nella foto seguente furono dettate dal Generale Giuseppe Garibaldi in persona che, come già detto, nutriva grande stima per questo eroico uomo del popolo.

Un sasso lo ricorda, gli amici conservarono la sua memoria.
Anche noi siamo amici di Francesco Moro e di tutti coloro che furono messi in catene per il loro pensiero e per una certa idea di Italia.

Andando a Staglieno a rendere dovuto omaggio ai padri della patria troverete pensatori, militari, figure di rilievo e personaggi illustri, tra loro c’è anche Francesco Bartolomeo Savi che è a me tanto caro.
Andando a Staglieno a rendere il dovuto omaggio a Giuseppe Mazzini volgete lo sguardo anche verso colui che fu amico suo, suo sodale e suo compagno.
Lui era Francesco Moro, detto il Baxaicò, tipo glorioso degli eroici popolani.